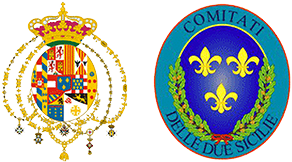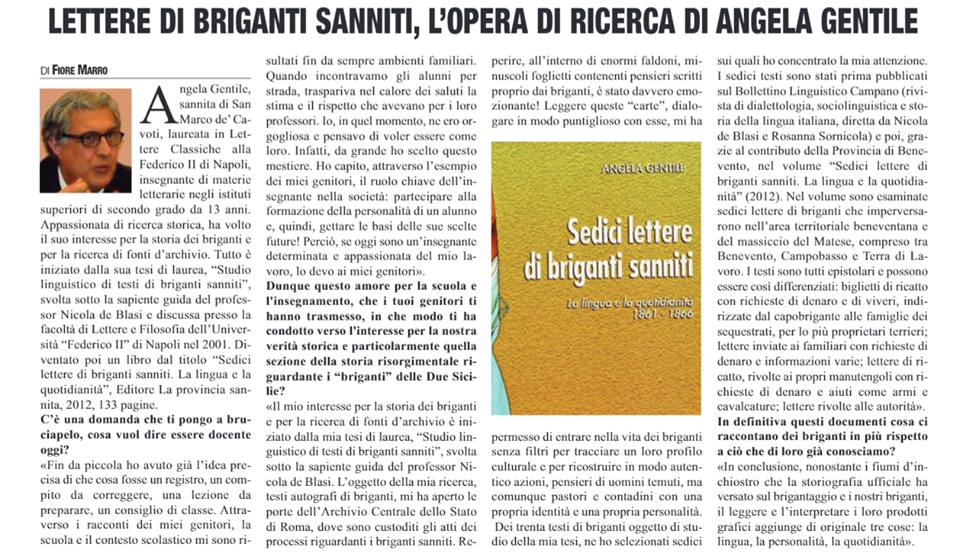Lettere di Briganti Sanniti, intervista all’autrice Angela Gentile
Di Fiore Marro
Caserta 21 settembre 2018
Angela Gentile, sannita di San Marco dè Cavoti, laureata in Lettere Classiche alla Federico II di Napoli e insegno materie letterarie negli Istituti Superiori di II Grado da 13 anni. Appassionata di ricerca storica ha volto il suo interesse per la storia dei briganti e per la ricerca di fonti d’archivio. Tutto è iniziato dalla sua tesi di laurea “Studio linguistico di testi di briganti sanniti”, svolta sotto la sapiente guida del prof. Nicola de Blasi e discussa presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università “Federico II” di Napoli nell’A.A. 2000-2001. Diventato poi un libro dal titolo“Sedici lettere di briganti sanniti. La lingua e la quotidianità” Editore La provincia sannita, 2012, 133 pagine .
D) C’è una domanda che ti pongo a bruciapelo, cosa vuol dire essere docente oggi?
R) Fin da piccola ho avuto già l’idea precisa di che cosa fosse un registro, un compito da correggere, una lezione da preparare, un Consiglio di Classe. Attraverso i racconti dei miei genitori, la scuola e il contesto scolastico mi sono risultati fin da sempre ambienti familiari. Quando incontravamo gli alunni per strada, traspariva nel calore dei saluti la stima e il rispetto che avevano per i loro professori. Io, in quel momento, ne ero orgogliosa e pensavo di voler essere come loro. Infatti, da grande ho scelto questo mestiere. Ho capito, attraverso l’esempio dei miei genitori, il ruolo chiave dell’insegnante nella società: partecipare alla formazione della personalità di un alunno e, quindi, gettare le basi delle sue scelte future! Perciò, se oggi sono un’insegnante determinata e appassionata del mio lavoro, lo devo ai miei genitori.
Quotidianamente metto in pratica i loro insegnamenti. Infatti, il mio obiettivo primario è motivare i ragazzi all’apprendimento, ottenendone la stima, cercando di essere seria, autorevole, coerente e determinata nel raggiungimento di obiettivi precisi per il loro successo a scuola e nella vita. Come i miei genitori mi dicono sempre, i ragazzi prima di tutto devono percepire che l’insegnante lavora per loro. Per ottenere questo ci vuole determinazione e tanta pazienza, poiché i frutti di questo lavoro non sempre si vedono subito o non sono proprio evidenti. A volte bisogna sapersi accontentare di tenui segnali che però rappresentano il motivo per non arrendersi, soprattutto per i ragazzi più problematici che non sono pochi.
2) Dunque questo amore per la scuola e l’insegnamento, che i tuoi genitori ti hanno trasmesso, in che modo ti ha condotto verso l’interesse per la nostra verità storica e particolarmente quella sezione della storia risorgimentale riguardante i “briganti” delle Due Sicilie?
Il mio interesse per la storia dei briganti e per la ricerca di fonti d’archivio. Tutto è iniziato dalla mia tesi di laurea “Studio linguistico di testi di briganti sanniti”, svolta sotto la sapiente guida del prof. Nicola de Blasi e discussa presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università “Federico II” di Napoli nell’A.A. 2000-2001.
L’oggetto della mia ricerca, testi autografi di briganti, mi ha aperto le porte dell’Archivio Centrale dello Stato di Roma, dove sono custoditi gli atti dei processi riguardanti i briganti sanniti. Reperire, all’interno di enormi faldoni, minuscoli foglietti contenenti pensieri scritti proprio dai briganti, è stato davvero emozionante! Leggere queste “carte”, dialogare in modo puntiglioso con esse, mi ha permesso di entrare nella vita dei briganti senza filtri per tracciare un loro profilo culturale e per ricostruire in modo autentico, azioni, pensieri di uomini temuti, ma comunque pastori e contadini con una propria identità e una propria personalità.
Dei trenta testi di briganti, oggetto di studio della mia tesi, ne ho selezionato sedici sui quali ho concentrato la mia attenzione. I sedici testi sono stati prima pubblicati sul Bollettino Linguistico Campano (rivista di dialettologia, sociolinguistica e storia della lingua italiana, diretta da Nicola De Blasi e Rosanna Sornicola) e poi, grazie al contributo della Provincia di Benevento, nel volume “Sedici lettere di briganti sanniti. La lingua e la quotidianità” (2012).
Nel volume sono esaminate sedici lettere di briganti che imperversarono nell’area territoriale beneventana e del massiccio del Matese, compreso tra Benevento, Campobasso e Terra di Lavoro. I testi sono tutti epistolari e possono essere così differenziati: biglietti di ricatto con richieste di denaro e di viveri, indirizzate dal capobrigante alle famiglie dei sequestrati, per lo più proprietari terrieri; lettere inviate ai familiari con richieste di denaro e informazioni varie; lettere di ricatto, rivolte ai propri manutengoli con richieste di denaro e aiuti come armi e cavalcature; lettere rivolte alle autorità.
3) Queste testimonianze epistolari perché ritieni abbiano importanza?
Si tratta di testi che hanno un indubbio valore storico come testimonianze dirette per capire più a fondo le componenti del complesso fenomeno del Brigantaggio. Tuttavia, io mi sono concentrata sull’analisi degli aspetti linguistici.
4) La narrazione manualistica italiana vuole i briganti come uomini incolti espressione di una naturalità corrotta e brutale, soggiogata da una primitiva istintualità. Chi sono, invece, per te, i briganti?
I briganti appartengono a pieno titolo alla categoria dei semicolti: sono personaggi di ridotta alfabetizzazione, che, solo eccezionalmente, affidano i propri pensieri alla carta e alla penna. Leggere i loro testi significa muoversi in un mare magnum di termini dialettali e regionali, affiancati da voci di provenienza scolastica e burocratica; pertanto possono essere definiti frammenti di parlato tramandatici per iscritto.
Caro timaso, scrive il brigante Libero Albanese, li vostro Figlio Sine Fugito…Si noi volemo esero amico mandatomi illo ricatto Si voi non mi manno illo ricatto jo vi distrugo quanto voi Beno teneto… si moro io cistano li mio comBagno…Si tacappe… ti cave na stagata…ti leve dallo monti. Si tratta di un biglietto di ricatto che il brigante Libero Albanese, fratello del celeberrimo capobanda Michelangelo, invia ad un certo Tommaso Buttini, padre del sequestrato Liberato Buttini. È certamente un documento storico a conferma del fatto che estorsioni, ricatti e rapine erano pane quotidiano per le bande di briganti. Se però il lettore, soprattutto se meridionale, spostasse l’attenzione sugli aspetti grafico-linguistici, innanzitutto riconoscerebbe nel testo due tra le più consuete abitudini dialettali: la pronuncia del gruppo consonantico –nd- come –nn- (manno); la pronuncia della –p- come sonora cioè –b- dopo una nasale (comBagno). Non sfuggirebbero le forme verbali dialettali volemo ‘vogliamo’ e moro ‘muoio’ e la forma na dell’articolo indeterminativo ‘una’. Sono invece riferibili al basso livello di scolarizzazione piuttosto che al dialetto gli scempiamenti consonantici impropri come timaso, esero, distrugo, stano. Inoltre è interessante notare che il brigante Albanese non conosce la morfologia minuscola della b e della f (Beno, comBagno, Figlio, Fugito), essendo la sua educazione grafica incerta ed incompleta.
All’interno dei testi, non mancano locuzioni tipiche del repertorio brigantesco e frasi di tono proverbiale. Ad esempio, il brigante di Baselice Antonio Secola è stato costretto a darsi alla campagna ‘darsi alla macchia’, ossia ‘diventare brigante’, a causa dei tanti fusi ‘maldicenze e accuse’ che gli evano imposto ‘gli avevano attribuito’: il riferimento è al detto dialettale “appendere i fusi a qln.”, ossia ‘dir male di uno, trovare dei difetti’. Proprio nelle lettere di Antonio Secola sono particolarmente frequenti forme di derivazione burocratica. Dal carcere di Caserta, il brigante invia una richiesta di denaro ai baselicesi D. Vincenzo e D. Giovannino, perché è accaiosa di appella, esorta ad inviarglielo (nel testo usa il verbo rimettere) non appena giunge la prisente e conclude mi dico vostro fidel servitore: un finale che rinvia ad un formulario abituale per rivolgersi a personaggi illustri e ad autorità. Insomma, siamo nell’ambito della scrittura popolare, propria di chi ha un basso livello d’istruzione, ma non è un dato di poco conto che questi briganti, contadini e pastori, fossero in grado di leggere e scrivere, in un momento in cui il tasso di analfabetismo era altissimo al Sud. A volte, proprio la vita di brigante offre a molti di essi l’occasione per la pratica della scrittura stessa.
5) Consiglieresti, anche a coloro che hanno strumenti culturalmente meno atti ad una corretta interpretazione , la lettura di questi testi?
Leggere queste scritture potrebbe risultare affascinante per qualunque lettore, perché sono un’esclusiva chiave d’accesso per entrare nella viva e cruda quotidianità dei briganti. Se le minacce dei biglietti di ricatto fanno di essi dei feroci criminali senza scrupoli, nelle lettere inviate ai familiari emerge il lato più umano dei nostri scriventi semicolti. In esse risaltano le difficoltà, gli stenti di una vita da latitanti e un legame affettivo profondo, nostalgico con la famiglia e la terra natia. Il brigante Giuseppe Cutillo di Solopaca, dal confino di Sora, invia una lettera alla Carissima zi archangela, nella quale sollecita l’invio di piastre 36, 3 cammiscie le scarpe e la cammisciola, perché si ritrova con una terribbela maladia…ignute e scalize: riesce a sopravvivere grazie ad una bonda di buono cristiane e qualiche divote per certo straccia e li mosina. È particolarmente significativa la lunga lettera che il brigante Pasquale Maturi indirizza alla moglie dallo Stato Pontificio, dove aveva trovato rifugio. Egli tanta e tanta volte l’ha mantate achiamare, poiché è suo desiderio che lei lo raggiunga magari con tutti li Figlio. È consapevole della mole di responsabilità che sua moglie ha, a causa della sua lontananza, perciò non esita a darle opportuni consigli su come sbarcare il lunario: stato sempere accorto alli aFFari toi […] aFFittare il paesi e la casa a quel persone che ti pono pacare. Inoltre, la parte finale della lettera è un vero e proprio elenco di nomi di persone, per lo più parenti, ai quali il brigante porge i suoi saluti, quasi per rievocare la socialità perduta!
Questi testi, dunque, rappresentano per i nostri briganti l’unico filo di collegamento con la loro terra, l’unico modo per continuare a far parte, anche se idealmente, della vita dei piccoli borghi sanniti. Insomma sono abili e arditi capibanda, colpevoli di eccidi, sequestri, furti e violenze minori, ma pur sempre contadini, pastori, braccianti: uomini con una storia alle spalle, una propria identità, una propria vita, una propria personalità.
6) In definitiva questi documenti cosa ci raccontano dei briganti in più rispetto a ciò che di loro già conosciamo?
In conclusione, nonostante i fiumi d’inchiostro che la storiografia ufficiale ha versato sul Brigantaggio e i nostri briganti, che cosa potrebbe aggiungere di originale il vedere, il leggere e l’interpretare i loro prodotti grafici? La risposta può essere condensata in sole tre parole: la lingua, la personalità, la quotidianità.