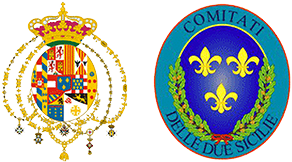Quando si parla del canto dei Sanfedisti, ritornano alla mente le vicende della Repubblica Partenopea e del breve periodo in cui Napoli fu nelle mani dei francesi rivoluzionari. Ma perchA? e dove nasce questo canto? Come diventa “dei Sanfedisti”? E a quali eventi di quel particolare periodo storico fa riferimento?
Quando si parla del canto dei Sanfedisti, ritornano alla mente le vicende della Repubblica Partenopea e del breve periodo in cui Napoli fu nelle mani dei francesi rivoluzionari. Ma perchA? e dove nasce questo canto? Come diventa “dei Sanfedisti”? E a quali eventi di quel particolare periodo storico fa riferimento?
Partiamo, come sempre, dall”inizio e riportiamo un pA? di storia; Carmagnola si trovava in provincia di Torino ed era un territorio noto per la produzione della canapa; dopo l”arrivo dei Savoia, molti canapai emigrarono nella vicina Francia portando con sAi?? le loro tradizioni, i loro abiti e i loro canti. I francesi per parte loro chiamarono “La Carmagnole” la giubba, i canti e i balli dei canapai emigrati. In piena rivoluzione francese, nel 1792, i sans-coulottes francesi adottarono la giubba, il berretto frigio e una ballata col testo adattato agli avvenimenti e li chiamarono “La Carmagnole”, diffondendoli nell”intera Francia. “La Carmagnole” divenne cosAi?? la canzone delle rivoluzioni e ve ne furono diverse versioni.
Noi parleremo qui della sua versione napoletana, che giunse nell”allora capitale del Regno nel 1799 assieme ai francesi che accorrevano a sostegno della Repubblica Partenopea proclamata dai giacobini napoletani. Questa canzone fu l”unica cosa francese accettata dal popolo che, nei mesi di occupazione, ne modificA? il testo esprimendo attraverso di esso la sua fedeltAi?? al Re Borbone. Veniamo ora al testo che recita cosAi??:
A lu suono de grancascia
viva viva lu popolo bascio.
A lu suono d”o tammurriello
sA? risurte li puverielli;
a lu suono de campana
viva viva li pupulane;
a lu suono de viuline
morte alli giacubine! (strofa 1)
Sona sona – sona Carmagnola
sona li cunsiglia – viva ”o Rre cu la famiglia! (** rit.)
A Sant”Eremo tanta forte
l”hanno fatto comm”a ricotta
a stu curnuto sbrevugnato
l”hanno miso ”a mitria n”capa.
MaistAi?? chi t”ha traduto?
Chistu stommaco chi ha avuto?
”E signure, ”e cavaliere
te vulevano priggiuniere! (strofa 2)
(** rit.)
Alli tridece de giugno Sant”Antonio gluriuso
”e signure, sti birbante
”e ffacettero ”o mazzo tanto!
So” venute li francise
auti tasse ”nce hanno mise
“LibertA?, egalitA?”:
tu arruobbe a mme
ie arruobbe a tte! (strofa 3)
(**rit.)
Li francise so” arrivate
”nce hanno buone carusate
“et voilAi??, et voilAi??”
cavece ”nculo a la libbertAi??!
AddA? A? gghiuta ”onna Eleonora
che abballava n”copp”o triato
mo abballa mmiez””o mercato
”nzieme cu Masto Donato! (strofa 4)
(** rit.)
A lu ponte a Maddalena
”onna Luisa A? asciuta prena
”e tra miedece che vanno
nun la pA?nno fAi?? sgravAi??! (strofa 5)
(** rit.)
”A lu muolo senza guerra
se tirajene l”albero ”nterra
afferrajeno ”e giacubbine
”e ffacettero ”na mappina!
”E fernuta l”eguaglianza
A? fernuta la libbertAi??.
Pe” vuje su” dulure ”e panza
signA? jateve a cuccAi??! (strofa 6)
(** rit.)
Passaje lu mese chiuvuso
lu ventuso e l”addiruso.
a lu mese ca se vene
hanno avuto l”aglio arrete!
Viva tata Maccarone
ca rispetta la Religgione
Giacubine jate a mare
mA? v”abbrucia lu panaro! (strofa 7)
(** rit.)
rn
Il ritornello incita alla rivolta al suono della Carmagnola (Sona sona, sona Carmagnola) e poi rafforza il suo invito dicendo “suona l”adunata, o il consiglio, viva il Re e la sua famiglia!”. Nella prima strofa si richiama il popolo alla guerra, ogni strumento A? in funzione della rima per un popolano o per il nemico da abbattere: la grancassa per il popolino, il tamburello per i nullatenenti, la campana per il popolo (artigiani ecc.) e violino per spiegare il motivo della lotta, cioA? cacciare i giacobini.
La seconfa strofa narra l”inizio della repubblica con la resistenza dei popolani, detti “i Lazzari”, asserragliati a Castel Sant”Elemo, un forte massiccio, conquistato dai francesi di Championnet che invece sostenevano la repubblica; si narra poi della presenza tra questi francesi, del prete giacobino Antonio Toscano, per passare poi al tradimento dei nobili e dei borghesi che volevano addirittura imprigionare il Re, cosa non certo voluta dal popolo che ha subito le conseguenze del tradimento e le prepotenze dei francesi.
Nella terza strofa troviamo inevece descritta la fine della repubblica, il 13 giugno, il giorno di S. Antonio, quando le truppe del Cardinale Ruffo di Calabria entrarono a Napoli, conquistando il Forte Vigliena a levante del Porto. Ecco che allora i popolani ripagano i giacobini per le angherie subAi??te, ovvero le alte tase imposte dai francesi e l”uso del motto rivoluzionario “libertA?, egalitA?, fraternitA?” per commettere ruberie e soprusi (ancora oggi A? rimasto in dialetto un ricordo di quei tempi nel detto “libertA?, egalitA? fraternitA?, spuogliete tu e vesteme a mme!”).
La quarta strofa prosegue narrando ancora le prodezze dei francesi che le hanno date di santa ragione al popolo e dicendo voilAi??, hanno preso a calci ogni libertAi??. Ora non si puA? piA? andare a teatro (una mania dei napoletani) e quindi Donna Eleonora A? costretta ad esibirsi al mercato. Su questa figura bisogna dire che non A? certo, ma potrebbe trattarsi di Eleonora Pimentel Fonseca, arrestata e giustiziata per impiccagione, infatti “ballare” potrebbe essere inteso come il corpo che penzola dalla forca, anche perchA? Masto Donato era il boia incaricato delle esecuzioni in quegli anni.
Si parla poi nella quinta strofa di Donna Luisa, forse Luisa Fortunato de Molina Sanfelice, amante del giacobino Ferdinando Ferri. Per salvare l”amato che rischiava l”arresto, ella venne a sua volta imprigionata e per sfuggire alla pena capitale affermA? di essere incinta.. nessun medico perA? riusciva a farla partorire.
Nella sesta strofa ormai la guerra ai giacobini A? terminata con la loro sconfitta e si butta l”albero a terra, si tratta dell””albero di maggio”, albero della libertAi?? e simbolo della rivoluzione. I popolani arrabbiati afferrano i giacobini e li appallottolano come stracci, si vendicano cioA? dei torti subAi??ti. Ritornano poi le parole “uguaglianza” e “libertAi??” e i napoletani sono contenti che siano finite, per chi ha perso sono dolori e quindi i perdenti possono andare a dormire, cioA? andare a ritirarsi.
La strofa finale A? molto ironica: riprende i mesi con i nomi del calendario rivoluzionario francese; “passA? il mese piovoso, il ventoso e l”iroso” cioA? gennaio, febbraio e marzo e “a lu mese ca se vene hanno avuto l”aglio arrete” nel mese entrante, cioA? giugno i giacobini hanno subito il danno e la beffa, un buon motivo epr dire che l”aglio brucia, soprattutto nel didietro! Infine ” viva il popolo dei maccheroni, cioA? il popolo napoletano, che rispetta la religione negata ai giacobini, i quali sono invitati a buttarsi a mare, riprendendo il discorso di prima sull”aglio, per spegnere i bruciori; in sostanza li si manda a quel paese. Tale ballata popolare A? storia scritta di pugno dal popolo, ben diversa dalla storia degli scrittori asserviti ai fasli miti risorgimentali che avrebbero definito la repubblica partenopea come “voluta dal popolo”. Dalla lettura de “la Carmagnola” si apprende la vera storia di quel periodo: un popolo che aveva in odio i giacobini e un tentativo riformatore e innovatore da parte dei repubblicani o giacobini napoletani, i quali si fecero prendere troppo la mano combinando un disastro quale la repubblica partenopea fu. Non si capAi?? infatti, che Napoli non era Parigi e che a Napoli il popolo non sentiva il bisogno di cambiar regime, perchA? aveva giAi?? le sue certezze.
Chiara Foti